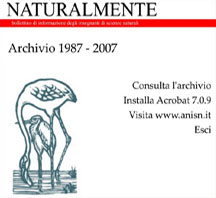Coreografie aeree
Valentina Vitali
A vacuolo, a cordone, flash expansion. A cosa corrispondono questi criptici nomi? Alle particolarissime, ipnotiche e spettacolari forme create dagli stormi di uccelli in volo, che caratterizzano i cieli autunnali e invernali di molte città. La specie protagonista di queste elaborate coreografie celesti è in molti casi lo storno europeo (Sturnus vulgaris), uccello dal piumaggio nero con riflessi iridescenti che sfumano dal viola al verde; è originario dell’Eurasia ma è stato introdotto in molti altri Paesi ed è per questo estremamente diffuso. In Italia la specie passa durante la propria migrazione verso le zone più meridionali, in cui sverna, ed è durante le ore tardo pomeridiane che è più facile godere degli spettacoli aerei messi in scena dagli storni prima di ritornare ai propri dormitori sugli alberi o sugli edifici, dopo essersi spostati anche di vari kilometri durante il giorno alla ricerca di risorse alimentari. L’aspetto affascinante e rimasto a lungo inspiegabile anche per la scienza è che questi stormi possono arrivare a comprendere fino a 750000 esemplari che si coordinano alla perfezione muovendosi in modo estremamente rapido. Com’è possibile? Uno studio condotto dal CNR-Istituto dei Sistemi Complessi (gruppo di lavoro coordinato da Andrea Cavagna e Irene Giardina) è riuscito finalmente a modellizzare il volo di questi organismi grazie a delle riprese video realizzate sui tetti di Roma agli storni della città utilizzando tre diverse telecamere, così da ottenere una visione tridimensionale, stereoscopica e non solo bidimensionale. È emerso che non esiste alcun leader, come invece molti studiosi avevano ipotizzato, ma un relativamente semplice meccanismo di coordinazione e imitazione a livello locale detto scale-free behavioral correlation (correlazione comportamentale a invarianza di scala). In sostanza quando un singolo storno sta volando imita la velocità e la direzione degli esemplari più vicini a sé. L’individuazione di tali esemplari di riferimento non si basa su una discriminazione spaziale (si seguono gli storni che distano al massimo qualche metro) e non è nemmeno influenzata dalla densità del gruppo; ogni individuo segue esattamente 7 altri esemplari che ha attorno, indipendentemente dalla loro distanza. Tale regola potrebbe sembrare illogica ma è in realtà molto efficace per mantenere la coesione del gruppo. Se un predatore, ad esempio un falco pellegrino, si avvicina velocemente ad uno stormo, in corrispondenza del predatore la densità del gruppo si riduce rapidamente perché gli uccelli si spostano per mettersi al sicuro e di conseguenza gli individui perderebbero la coesione con il gruppo perché i riferimenti sarebbero troppo distanti; con l’utilizzo di un’interazione basata sul numero di compagni da imitare a prescindere dalla loro distanza la coesione è al contrario perfettamente mantenuta. Coordinare il proprio movimento con altri compagni vicini non è affatto semplice ed è una capacità che gli storni allenano anche in altre situazioni. In una recente ricerca (Social birds copy each other's lateral scans while monitoring group mates with low-acuity vision, 2016) è stato osservato che anche quando gli storni rimangono appollaiati in gruppo tendono a monitorarsi con i conspecifici e a replicarne i comportamenti; in particolare vengono copiate dai vicini le tempistiche delle scansioni laterali, che consistono in piccoli ma continui spostamenti da un lato all’altro della testa, posizionata verso l’alto, allo scopo di tenere sotto controllo l’ambiente circostante, sia per accorgersi dell’arrivo di un predatore che per raccogliere informazioni sociali su altri individui. Questa consuetudine potrebbe essere utile per abituarsi a rispondere rapidamente ai movimenti dei compagni anche durante le mormorazioni (così vengono chiamate le coreografie aeree degli storni, in genere accompagnate dal fruscio delle ali e dal vociare degli uccelli). Bisogna poi considerare che gli storni sono dotati di un ampio campo visivo: la zona di visione binoculare (percezione con entrambi gli occhi) è di circa 26° ma ogni occhio è in grado di vedere singolarmente per altri 135°, di conseguenza solo una ridotta zona (64°) alle spalle dell’esemplare è cieca. Questo ampio campo visivo generale rappresenta un vantaggio per le scansioni laterali, che vengono eseguite utilizzando la visione retinica periferica e non quella centrale in corrispondenza della fovea (area centrale a massima acutezza visiva); così facendo gli uccelli si basano su una qualità visiva evidentemente inferiore ma possono ridurre i costi del monitoraggio poiché riescono contemporaneamente a osservare i compagni e a controllare l’arrivo di un eventuale predatore. Oltre a comprendere come gli storni riescono a visualizzare i loro riferimenti in volo nello stormo è interessante interrogarsi sul perché decidono di coordinarsi esattamente con altri 7 vicini; è un numero casuale oppure c’è una sorta di conteggio alla base? La capacità di contare degli uccelli è stata indagata attraverso vari esperimenti e in uno in particolare (Neurons in the Endbrain of Numerically Naive Crows Spontaneously Encode Visual Numerosity, 2018) è stato chiesto a due cornacchie nere di eseguire dei test al computer volti a discriminare il colore di puntini che apparivano sullo schermo; gli esemplari erano quindi stati addestrati a distinguere le differenze cromatiche ma non a riconoscere i numeri degli elementi. Ciononostante misurandone l’attività cerebrale è stato rilevato che alcuni neuroni si attivavano solo in corrispondenza di precise quantità, per esempio dopo aver superato un certo numero di puntini, dimostrando che esiste spontaneamente nei corvidi e quindi probabilmente anche negli storni un senso della numerosità, forse evoluto perché garantisce molti vantaggi in natura (riconoscimento della fonte alimentare più abbondante per esempio). In un altro esperimento neozelandese dei piccioni hanno dimostrato di riuscire a ordinare degli elementi in senso crescente in base alla numerosità (3 è stato riconosciuto più piccolo di 4, 7 più grande di 5). Si può quindi ragionevolmente ipotizzare che gli storni contino i compagni di riferimento e che il numero 7 sia il limite massimo di individui da tenere sotto controllo. Lo studio del CNR ha voluto rilevare anche il grado di correlazione cioè di influenza di un esemplare su un altro che è poi strettamente correlato alla velocità con cui un’informazione viene trasmessa all’interno del gruppo. Il dato davvero sorprendente è che la variazione di un individuo nella direzione o nella velocità (per effetto dell’arrivo di un predatore ad esempio) si propaga nel giro di mezzo secondo ad altri 400 esemplari (cioè ad una distanza di circa 300 m). Ciò significa che nonostante l’interazione sia locale la correlazione è ad ampio raggio quindi il comportamento di un singolo individuo è in grado di influenzare un intero stormo. Comprendere le regole alla base di queste ipnotiche danze non permette però ancora di rispondere ad una domanda fondamentale: perché lo fanno? È vero che muoversi in stormi numerosi confonde il predatore e toglie l’attenzione dal singolo esemplare quindi la finalità sarebbe rivolta a minimizzare il rischio di essere predati ma gli storni a fine giornata non si limitano semplicemente a raggiungere in gruppo i dormitori e a fermarsi ma rimangono a volare per molto tempo, anche 45 minuti, talvolta senza che nessun predatore si presenti e sprecando molta energia. Cosa li spingerà a farlo?