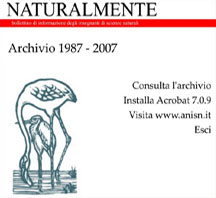Giornata di NATURALMENTE Scienza 2 dic 2023
Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa certosa di Calci
Incontro Naturalmente Scienza-Alessandra Borghini ETS • Ecco s’avanza una strana rivista… Maria Turchetto • Scienza e democrazia: la trasformazione degli ideali del sapere • Biodiversità vegetale e invasioni biologiche • Biodiversità e invasioni aliene

Incontro Naturalmente Scienza – 2 dicembre 2023
Alessandra Borghini
Ringrazio a nome mio personale e a nome di Edizioni ETS che qui rappresento, la direttrice del Museo, la dott.ssa Elena Bonaccorsi, i prestigiosi relatori degli interventi che seguiranno e tutti gli amici di “Naturalmente Scienze A.P.S.”
Sono davvero molto legata a questo progetto che vanta una lunga storia, che ho avuto il privilegio di condividere per diversi anni occupandomi personalmente in casa editrice della pubblicazione della rivista .
Negli ultimi anni la redazione che lo guida, nelle persone di Vincenzo Terreni, Maria Turchetto e dei loro collaboratori, è stata capace di farlo crescere e sviluppare in nuove direzioni.
Se la spinta originaria di questa iniziativa editoriale era fornita dalla scuola, l’ambiente che ha riunito il nucleo fondatore della rivista, oggi “NaturalmenteScienza” è un progetto inserito nel dibattito scientifico, volenteroso di coniugare l’osservazione del territorio con l’acquisizione di uno sguardo più ampio sulle sfide ambientali che il nostro paese si trova ad affrontare.
La collaborazione con ETS, interrottasi per un periodo, è ripresa da quattro anni a questa parte, da subito nel solco dell’accordo tra tradizione cartacea e innovazione digitale.
Oggi Naturalmente scienza è una rivista che vanta un pubblico di lettrici e lettori, che seguono le sue uscite e sostengono il progetto editoriale anche con la sottoscrizione degli abbonamenti.
Si tratta di cinquanta abbonati alle uscite in forma elettronica, che ricevono quindi il fascicolo in formato pdf, e una ventina di “affezionati”, a cui inviamo anche il fascicolo cartaceo.
A seguire gli aggiornamenti relativi alla rivista non sono comunque solo gli abbonati. Grazie a un ricco indirizzario formulato dalla direzione del sito, che viene aggiornato periodicamente, siamo in grado di segnalare l’uscita dei fascicoli a circa quattrocento lettori e lettrici, che teniamo al corrente dei temi trattati di volta in volta all’interno delle pubblicazioni, con l’obbiettivo di incrementare ulteriormente il numero degli abbonati.
A questi si aggiungono i contatti di ETS che ricevono mensilmente le comunicazioni in merito alle novità pubblicate.
Negli ultimi mesi, inoltre, il progetto di Naturalmente scienza ha consolidato ancor più la sua apertura digitale, in linea con il tempo in cui viviamo.
Il suo sito storico, costruito nel 2019, e ancora attivo per le comunicazioni relative alle attività dell’associazione, verrà presto affiancato da un nuovo portale che stiamo ultimando in queste settimane, che sarà riservato ai contenuti editoriali della rivista Naturalmente scienza.
Il nuovo sito è ospitato dalla piattaforma Open Journal System (OJS) che include i contenuti delle riviste, di ambito umanistico e scientifico applicato, riconosciute dal dibattito universitario e fondamentali per la ricerca e gli studi più aggiornati.
La piattaforma consente di rendere accessibili gli articoli con i dati a loro connessi, di raggiungere facilmente gli autori e la redazione. Essa facilita inoltre il processo di sottomissione di nuove proposte e assicura una pubblicazione trasparente, rendendo più immediata e visibile la cosiddetta “peer review”, la revisione cieca dei contributi pubblicati.
Le riviste che si avvalgono della piattaforma OJS, come Naturalmente, possono inoltre beneficiare di codici DOI che rendono i contenuti più accessibili al pubblico degli studiosi e che rendono subito riconoscibile la sorgente di pubblicazione.
Come Edizioni ETS abbiamo scelto di avvalerci di questo sistema di pubblicazione degli articoli scientifici già da diversi anni, consentendo alle nostre riviste di accrescere la loro popolarità, di consolidare la loro credibilità scientifica, di ampliare sempre più il loro pubblico di riferimento e di agevolare la procedura di iscrizione a prestigiosi indici internazionali.
Siamo contenti che anche Naturalmente abbia deciso di avvalersi di questa opportunità, certi che questa decisione coinciderà con un incremento della fortuna di questo longevo e importante progetto editoriale.
L’ultimo tassello del percorso che unisce Naturalmente e la nostra casa editrice riguarda ancora il rafforzamento della notorietà scientifica della rivista e, in particolare, la decisione della redazione di richiedere all’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca (Anvur) il riconoscimento formale di “rivista scientifica” in particolare per alcuni ambiti della ricerca umanistica.
Crediamo che ottenere questo riconoscimento sia importante per l’ispirazione storica di Naturalmente, che la configura come pregevole iniziativa di comunicazione scientifica.
Inoltre, ottenere tale riconoscimento incrementerà la motivazione dei giovani ricercatori, dottorandi e divulgatori a sottoporre le loro ricerche alla redazione, dal momento che, nel caso del suo ottenimento, gli articoli pubblicati sulla rivista saranno passibili di valutazione universitaria (potranno, ad esempio, essere presentati nelle richieste per l’abilitazione scientifica nazionale).
Quello che abbiamo intrapreso insieme è quindi un percorso ancora aperto, che speriamo essere solo all’inizio. E a questo proposito desidero ringraziare ancora tutti gli amici di Naturalmente per la collaborazione, sempre preziosa.
Auguro a tutti di trascorrere una piacevole giornata in questo luogo incantevole.

Ecco s’avanza una strana rivista…
Maria Turchetto
Presentazione della rivista in occasione della “Giornata di Naturalmente Scienza” del 2/12/2023
… titolo che ovviamente è una boutade (tratta da un canto comunista del 1919, intitolato La guardia rossa). Boutade a parte, tengo a spiegare perché Naturalmente Scienza è una rivista – almeno per alcuni aspetti – “strana”. È una rivista che ha tre caratteristiche
La prima è un forte interesse naturalistico, come documentano le rubriche “Ritratto di famiglia” (che presenta, in ciascun numero, un gruppo familiare biologico) e “Uno scatto alla natura” (dedicata al commento di foto particolarmente significative), ma anche molti articoli pubblicati. Fin qui, si tratta di divulgazione scientifica, per altro di ottimo livello – spesso un po’più che divulgazione, proponiamo approfondimenti che possono interessare gli specialisti, ma che comunque sono leggibili anche da non specialisti. In ogni caso, direi buona, ottima divulgazione scientifica e, aggiungo, non limitata alle scienze della vita.
La seconda caratteristica è la riflessione sulla didattica delle scienze (di nuovo, non solo le scienze della vita, l’insegnamento della fisica e della matematica è stato oggetto di molti contributi). La sezione “Fare scuola” rappresenta uno strumento prezioso per gli insegnanti. Oggi siamo in grado di offrirvi una bella raccolta degli articoli dedicati a questo argomento.
Fin qui… niente di “strano”, anche se sottolineo di nuovo l’ottimo livello degli interventi pubblicati.
La terza caratteristica è un approccio critico ai problemi della natura e della scienza: un aspetto “strano” o comunque originale, che caratterizza la rivista fin dalle sue origini – abbastanza risalenti, è nata nel 1987. Che cosa intendo per “approccio critico”? Fondamentalmente, l’aver sempre tenuto presente il rapporto con la società: natura e società, scienza e società.
Natura e società: per questo rapporto passano i problemi legati all’ecologia e alla crisi ambientale, di cui ci siamo sempre occupati. Nell’ultimo numero uscito, ad esempio, la sezione FOCUS è dedicata alle plastiche e al loro impatto ambientale; ma abbiamo affrontato in altri numeri i problemi energetici, l’emergenza climatica… Dire che lo abbiamo fatto con un approccio critico non è una banalità: abbiamo affrontato questi problemi non all’insegna del rapporto tra uomo e natura, come troppo spesso si fa negli ultimi tempi. Non è l’umanità nel suo complesso, né l’individuo con i suoi comportamenti a provocare danni, ma un certo tipo di sistema economico-sociale, le cui caratteristiche vanno conosciute e studiate per produrre non solo una critica efficace, ma anche provvedimenti efficaci – e non generici appelli.
Scienza e società: altro problema di cui ci siamo sempre occupati e che risulta francamente difficile da affrontare: richiede un approccio critico nel senso alto del termine. Nel prossimo numero della rivista, che uscirà a febbraio, ce ne occuperemo di nuovo. Innanzitutto con un contributo di Elena Gagliasso che ci parlerà di un difficile rapporto – quasi “schizofrenico” – che riguarda il nostro modo attuale, diverso dal passato, di valutare la scienza. Non le attribuiamo più un ruolo oggettivo, super partes, ma la riteniamo al tempo stesso corresponsabile di molti disastri, per essere entrata al servizio di forti interessi economici, e capace di risolverli – quanto meno di individuarli, documentarli e proporre possibili soluzioni. Sempre nel prossimo numero ci sarà un articolo di Giuseppe Longo che fornisce un esempio concreto in questo senso, parlando delle NTG (Nuove Tecnologie Genetiche) ossia nuovi OGM (Organismi Geneticamente Modificati) oggi proposti con forza al Parlamento Europeo come alternativa agli OGM attualmente vietati con una campagna basata su argomenti scientifici ma obsoleti quanto a presupposti teorici al punto da risultare “falsi”. Longo ci informa anche delle attività di organizzazioni di scienziati (come la Rete europea degli scienziati per la responsabilità sociale e ambientale) contro questi nuovi prodotti. Come si vede è la stessa comunità scientifica ad essere “schizofrenica”, quanto meno divisa tra una tecnoscienza (come la chiama Longo) al servizio di interessi economici che sembra addirittura ignorare elementari principi di cautela e una scienza responsabile.
La domanda che allora si pone è questa: come possiamo – in quanto cittadini, consapevoli e informati quanto si vuole, ma non certo specialisti – orientarci in uno scenario così difficile? Io credo che Naturalmente Scienza, questa “strana” rivista, possa darci una mano, proprio per il suo approccio critico e attento agli aspetti sociali. Quanto meno ci prova, cerca di farlo assumendo, in questo senso, un forte impegno civile.
Scienza e democrazia: la trasformazione degli ideali del sapere
Elena Gagliasso
Fare i conti con le ambivalenze della scienza
Abbiamo ricevuto dal passato un’immagine di scienza classica che per molte ragioni confligge con quella in corso. È una contraddizione tra l’ideale metodologico della trasparenza e del disinteresse neutrale rispetto a quella che è la realtà concreta della scienza detta “post-accademica” (Ziman, 2001; Kitcher, 20++), influenzata da due categorie di stakeholders: finanziari e sociali. Spesso tra di loro antagoniste. Ma la contraddizione si complica ulteriormente: c’è una corresponsabilità da un lato delle tecnoscienze con il sistema produttivistico e finanziario capitalistico che ha danneggiato gravemente l’ambiente terreste e c’è una documentabile fiducia che proprio da gran parte delle ricerche attuali possano arrivare diagnosi e indirettamente anche proposte per ripensare tale sistema in modo responsabile o elaborarne varianti (Artale, in Rfless Sist)
Nei due secoli scorsi e secondo una ‘grande accelerazione’, una importante parte della ricerca scientifica, con le sue ricadute tecnologiche, s’è ritrovata ad essere corresponsabile di effetti nocivi – impensati alla loro origine e responsabili ora dell’attuale catastrofe ambientale planetaria (pensiamo alle innovazioni tecnologiche del motore a scoppio e dei primi pozzi petroliferi, all’introduzione dei primi composti di sintesi come il DDT, e molte altre immissioni di sostanze oggi antagoniste alla vita).
Oggi, quasi contraddittoriamente, proprio molta ricerca è la chiave di volta per identificare il danno. Prevedere gli esiti di rischi futuri attraverso prospezioni e modellizzazioni, permette di avanzare proposte concrete di cambiamenti epocali. Contribuisce, grazie al convergere di molta ricerche, a riorientare nuove visioni del mondo volte alla riparazione e a introdurre, nei casi migliori etiche scientifiche e ambientali del ‘rammendo’ (Gagliasso, cnr) anche di priorità dell’economia e degli stili di vita.
L’impresa scientifica nella sua fase di avvio e di potenziamento dell’industrializzazione collegata all’economia capitalista perdurante non avrebbe potuto prefigurare che proprio da essa stessa, dalle scienze della Terra, dalla biologia evoluzionista, dall’ecologia, dalla medicina dalla zoologia, dalla botanica, dalla microbiologia e dall’epidemiologia ambientale, ma anche dalle tecnologie di prospezioni satellitari, oceanologiche, ecc., che numerosi prodotti tecnoscientifici del passato sarebbero stati individuati quali concause di quella sorta di pandemia al rallentatore che è oggi il collasso climatico.
Tutto ciò crea uno slittamento inedito di prospettive anche per l’epistemologia e chiama in causa le politiche e l’etica. In fondo se la falsificazione cruciale per demarcare la scienza per Karl Popper invece di essere giocata nel tempo breve dell’esperimentoe delle formulazioni si distendesse retrospettivamnte su una serie di generazioni umane, noi oggi potremmo osservarla realizzarsi in quella sorta di mega esperimento a cielo aperto in corso. Operatività e ideali del sapere dei nostri avi di fine Ottocento, nel secolo delle ‘magnifiche sorti e progressive’ del positivismo sono stati gravidi di controprove a distanza.
Gran parte dei problemi più gravi dell’attuale crisi climatica negli ultimi duecento anni sono dovuti a una sinergia incrementale tra produzione tecnoscientifica ed economia di rapina (o ‘predazione deviata’) del mondo vivente e non solo. Eppure proprio la ricerca scientifica (ambientale, epidemiologica, clinica, epigenetica) dimostra e documenta come determinate innovazioni siano (e saranno per lunghissimi tempi) gravemente inquinanti nel tempo. Le cosiddette “sostanze chimiche per sempre”, restano stabilmente nei suoli, nelle acque e nei corpi attraverso le catene trofiche alimentari di cui siamo il vertice di accumulazione. Questo dice la ricerca e questo additano le scienze della vita come negatività.
Fin dalla contaminazione radioattiva che dal 1945 ha ricoperto gran parte del pianeta con lo strato di isotopi dei test nucleari e delle bombe atomiche sul Giappone, oncologi, pediatri, zoologi, ecologi avevano monitorato questo stato di cose, offerto prospezioni tendenziali nel tempo e nello spazio di patologie conseguenti, agendo a distanza, come nel caso di Barry Commoner e di Helen Caldicott sui decisori politici. Modelli di conseguenze per tutto lo ‘stato vivente della materia’ sono dunque emersi proprio dalla crescita esponenziale di nuove teorie scientifiche e di nuove sofisticate tecnologie interagenti tra di loro, grazie al potenziamento di un buon uso del Big Data. Con le documentazioni fini dello stato di crisi planetaria, le ricerche parlano incessantemente alle governances geopolitiche globali, contribuiscono da decenni a strutturare i dati di rischio che hanno permesso i Protocolli ambientali, e entrano così nel vivo delle politiche e della società. Non a caso sono ascoltate con viva attenzione oggi dai nuovi movimenti ambientalisti, e contrastate invece dai grandi portatori di interessi finanziari e dai loro ‘esperti’ negazionisti climatici. Protocolli disattesi o volutamente ‘rallentati’ e procrastinati sono una sorta di guerra lenta e non dichiarata dei grandi potentati estrazionisti in difesa di profitti e status quo che l’emergenza in corso rischia di compromettere.
Si tratta dunque di un “doppio vincolo” insieme negativo e positivo della ricerca scientifica, e ci riguarda tutti. I cambiamenti della visione della scienza e della società che possono portare fiducia, crescita di conoscenze e consapevolezza, condivisione, sostanziano anche nuovi valori ma devono però affrontare ripulsa e diffidenza dei rinnovati oscurantismi in cerca dei più facili ‘paradigmi di rassicurazione’ umana (gli anni del Covid insegnano). Ciò non è indolore: implica in molti casi un conflitto troppo poco messo a tema tra campi disciplinari e comunità scientifiche (ricordiamo all’indomani della catastrofe di Chernobyl il contrasto tra le comunità dei fisici e ingegneri nucleari e quelle dei neonatologi e oncologi).
Tra “cambiamento” climatico ed “emergenza” climatica (in base ai dati di climatologi, glaciologi, oceanologi, naturalisti, microbiologi, virologi) si dà una vera e propria transizione epistemica che si intreccia con una trasformazione degli stili di vita e degli ideali del sapere. Si mettono così al lavoro ricerca, valori culturali, categorie che agiscono sulla mentalità collettiva e lentamente possono scalzare, o meglio, per ora contrastare, valori culturali e sociali ereditati dal recente passato: passando dall’ideale scientifico del dominio prometeico, egemone fino alla seconda metà del ’900 a quello di una scienza riparativa del danno.
Insomma anche l’esigenza di uscire dai modi di produzione nocivi ereditati, da scelte economiche perniciose per l’umanità intera (vantaggiose per una ristrettissima compagine di super ricchi), nonché dalle stesse abitudini o stili di vita dell’altro ieri ha un debito durevole con la ricerca scientifica attuale. Per evitare però in questa posizione di per sé virtuosa una deriva scientista occorre interrogare il mutamento di priorità dei temi che legano scienza e società. Un mutamento che sta anche alla base di sotterranee e nuove conflittualità tra temi di ricerca classici oppure emergenti, che sono retrostanti ai dati.
Ma interrogarsi anche a partire da ciò sulle possibili regressioni in corso.
Un esempio. Una Cop 28 per la tutela del clima e l’abbattimento del fossile giocata a Dubai tra novembre e dicembre 2023 sotto patrocinio degli Emirati, ovvero nel regno incontrastato dei petroldollari, laddove il consumo energivoro è al massimo (pensiamo alle piste da sci nel desetro) è ‘come se Dracula fosse il testimonial di una campagna per donare il sangue’.
Sotto gli occhi è dunque evidente che la trasformazione degli ideali del sapere, con la conversione delle forme di vita che vi si dovrebbero correlare non è e non sarà affatto indolore. Come ogni rivoluzione dello status quo non può non essere ostacolata dai precedenti beneficiari. In tutti i modi e con tutti i mezzi. Come ogni rivoluzione non sarà quindi un banchetto di gala ma una conflittualità con vincitori e vinti.
Biodiversità vegetale e invasioni biologiche
Lorenzo Peruzzi
PLANTSEED Lab, Dipartimento di Biologia / Orto e Museo Botanico, Sistema Museale di Ateneo, Università di Pisa
È sempre più difficile parlare di biodiversità vegetale, poiché nella nostra epoca moltissime persone hanno ormai perso il contatto con la natura e tendono a vedere le piante come un generico e anonimo oggetto di arredo o “sfondo verde” davanti al quale svolgere le proprie attività quotidiane. Questo fenomeno è ben noto ed è stato definito “cecità alle piante” (Wandersee & Schussler, 1999). Nonostante ciò, interessarsi, conoscere e proteggere la biodiversità vegetale è fondamentale, poiché è proprio dalle piante che dipende la vita sulla terra per come oggi la conosciamo. Stime recenti indicano che oltre l’80% della biomassa di ambienti emersi sul nostro pianeta sia costituita da piante, che in quanto produttori primari sono alla base di tutte le catene alimentari, inclusa ovviamente la nostra specie Homo sapiens Linnaeus, 1758 (Bar-On & al., 2018).
Assieme al consumo di suolo e al cambiamento climatico, uno dei principali problemi che nell’ultimo secolo stanno mettendo a rischio la biodiversità delle piante è il fenomeno delle invasioni biologiche (Corlett, 2016): la presenza, cioè, di specie introdotte – consapevolmente o inconsapevolmente – dall’uomo al di fuori del loro areale naturale. Normalmente, le piante sono introdotte in coltivazione in un determinato territorio per essere utilizzate come ornamento o alimento. Può succedere che alcune di queste specie aliene (definibili anche alloctone o esotiche) inizino a sfuggire alla coltivazione (aliene casuali) e che, col tempo, acquisiscano la capacità di autosostenersi e riprodursi autonomamente senza l’intervento dell’uomo (aliene naturalizzate). Una porzione di queste specie può trovarsi talmente bene in un territorio da iniziare a diffondersi in modo incontrollato, andando a sottrarre spazio alle specie native (definibili anche autoctone) presenti nello stesso territorio con dinamiche naturali, o addirittura a sostituirle completamente. Si parla in questo caso di specie aliene invasive (Pyšek & al., 2004).
Il problema è ben documentato dalla comunità scientifica a livello globale (es. Higgins & al., 1999; Heida & al., 2009; Vilà & al., 2011). Recentemente, l’Unione Europea ha preso coscienza degli enormi rischi connessi con le invasioni biologiche, emanando una serie di regolamenti con elenchi – periodicamente aggiornati – di specie animali e vegetali da non detenere, da non commercializzare, da monitorare in caso di rinvenimento in natura e da eradicare precocemente ove possibile (Regolamenti europeo UE 1143/2014 e Regolamenti applicativi UE 2016/1141, 2017/1263, 2019/1262 e 2022/1203). Tale regolamento è stato recepito dallo Stato italiano, che ha delegato alle Regioni la piena responsabilità della corretta gestione di questi organismi.
Secondo lo studio recentemente pubblicato da Galasso & al. (2024), la situazione in Italia risulta la seguente: su un totale di 10.023 specie/sottospecie di piante vascolari note a livello nazionale, 1.782 (17,8%) sono esotiche. Tra queste, abbiamo 796 casuali, 649 naturalizzate, 250 invasive. Delle 40 specie di piante vascolari (felci, equiseti e piante a seme) elencate nei sopra citati regolamenti europei, 22 sono segnalate per l’Italia come presenti in natura. In accordo con gli stessi autori, la situazione in Toscana è la seguente: 687 aliene (312 casuali, 274 naturalizzate, 116 invasive), tra cui la documentata presenza di 13 delle 22 di rilevanza unionale: Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Fabaceae), Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (Simaroubaceae), Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. (Amaranthaceae), Asclepias syriaca L. (Apocynaceae), Baccharis halimifolia L. (Asteraceae), Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone (Poaceae), Hydrocotyle ranunculoides L.f. (Araliaceae), Impatiens glandulifera Royle (Balsaminaceae), Myriophyllum aquaticum L. (Haloragaceae), Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven subsp. montevidensis (Spreng.) P.H.Raven, Pistia stratiotes L. (Araceae), Pontederia crassipes Mart. (Pontederiaceae), Pueraria lobata (Willd.) Ohwi (Fabaceae).
A fronte di corpose prove scientifiche che evidenziano i gravi danni prodotti dalle invasioni biologiche (Genovesi, 2024), oggi sempre più spesso nel mondo della divulgazione “scientifica” si assiste a una narrazione subdola ed estraniante, che vorrebbe vedere le piante aliene come delle intraprendenti giramondo che “sfruttano” l’uomo per diffondersi sempre più efficacemente sulla terra (Mancuso, 2018). Si arriva addirittura a fare dei parallelismi tra i movimenti delle specie aliene e le migrazioni delle popolazioni umane, con dichiarazioni scientificamente assurde quali “ci sono piante non autoctone [per un certo luogo, ndr] ma che lo diventeranno nel tempo” (Torreggiani, 2024). Accostare quanto avviene tra le diverse popolazioni di una medesima specie (Homo sapiens) con il fenomeno delle invasioni biologiche, che riguarda invece numerosissime specie diverse appartenenti ai più disparati gruppi di viventi, è completamente errato dal punto di vista scientifico. Inoltre, tutto ciò è anche molto pericoloso per le conseguenze che può avere nella formazione di una pubblica opinione su questi temi, portando facilmente a considerare i biologi della conservazione come “razzisti” e il contrasto alle invasioni biologiche come inutile o addirittura dannoso. Inoltre, stiamo assistendo a una crescente attenzione della cittadinanza nei confronti delle piante, ma solo grazie a una loro inopportuna antropomorfizzazione: le piante diventano “intelligenti”, “buone”, “altruiste” etc. (es. Simard, 2022).
Questo modo di sentire, associato alla ben nota e sopra citata cecità alle piante, porta però a non fare distinzioni tra un individuo di platano coltivato sotto casa e una piantina erbacea autoctona a estremo rischio di estinzione, di cui magari neppure si conosce l’esistenza. D’altra parte, se una pianta è bella o “utile”, ben venga la sua conoscenza, valorizzazione e tutela, se invece si tratta di una pianta che non riveste un interesse immediato per l’uomo, allora “a cosa serve”? Questa, tra l’altro, è la classica domanda che mi sento rivolgere quando mi capita di parlare di qualche specie selvatica della nostra flora al di fuori dell'ambito accademico. Le specie vegetali non sono intercambiabili a caso, ma questo messaggio non viene minimamente trasmesso e porta a dei gravi equivoci di fondo. Infatti, se elimino totalmente un prato che ospitava 50 specie autoctone, non posso pensare di compensare questa eliminazione – in termini di biodiversità – coltivando altrettante (o anche di più) specie, molte delle quali, magari, alloctone. Analogamente, piantare migliaia di alberi (magari, di nuovo, alloctoni) non crea un bosco, con le sue complesse e articolate interazioni biologiche, ma semplicemente una piantagione, cioè una sorta di “campo di alberi”: sarebbe come sostituire la Foresta Amazzonica con un enorme campo di palme da olio pensando di fare del bene al pianeta! È necessario ricordare che esistono oltre 377.000 specie diverse di piante terrestri (https://www.worldfloraonline.org/), ognuna con la propria distribuzione, peculiarità, adattamenti.
Cos’è quindi la biodiversità vegetale? Su questo punto conviene sgombrare il campo da equivoci. La biodiversità vegetale è l’insieme di tutte le specie selvatiche di piante (inclusa la loro diversità genetica), che si associano a formare comunità vegetali differenti a seconda dal clima e delle caratteristiche di un luogo (Wilson, 1988). Quindi nulla hanno a che vedere con la biodiversità la presenza o la coltivazione di piante alloctone e neppure la cosiddetta agrobiodiversità, es. varietà coltivate di piante, razze di bovini o altri animali etc. Queste ultime, in particolare, hanno certamente molta rilevanza di tipo culturale e/o economica per l’uomo (Kontoleon & al. 2009), ma nessuna nel contesto della biodiversità “reale”. La confusione regna sovrana nell’opinione pubblica su questi temi. Si può arrivare a situazioni assurde, per cui ad esempio l’eradicazione dalle spiagge di una pianta fortemente invasiva come il fico degli Ottentotti (Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus, Aizoaceae), per la bellezza della specie viene osteggiata dalle popolazioni locali, mentre magari di una specie vegetale autoctona sull’orlo dell’estinzione (es. Solidago virgaurea L. subsp. litoralis (Savi) Briq. & Cavill., endemica delle coste sabbiose toscane) non importa niente a nessuno.
A mio avviso, la visione distorta delle piante aliene sopra descritta si colloca in un più ampio modo di vedere: anche noi siamo animali, quindi parte della natura. Qualunque tipo di attività umana, pertanto, è lecita e non dobbiamo preoccuparci troppo delle conseguenze delle nostre azioni. In un contesto come questo, ovviamente, anche la presenza di piante aliene in un territorio è vista come “naturale”.
C’è però un problema etico: con le sue attività, l’essere umano si sta consapevolmente assumendo la responsabilità di causare l’estinzione di un numero enorme di specie animali e vegetali selvatiche (Ceballos & al., 2015), favorendo – al contrario – un numero ristretto di specie che tollerano meglio di altre le modifiche ambientali da noi indotte (Ruddimann, 2013). Abbiamo, in quanto esseri autocoscienti (Korzeniewski, 2020), diritto di vita e di morte su tutti gli altri esseri viventi? O non dovremmo invece sentirci in dovere di cercare soluzioni per mitigare il nostro catastrofico impatto sul pianeta (Chiarucci, 2024)?
Anche non volendo entrare negli aspetti etici, c’è un altro problema molto più pratico. Agire senza freni e senza porsi problemi non porterà certamente alla scomparsa della vita sulla terra, come qualcuno potrebbe pensare. Gli organismi viventi nel loro complesso, negli oltre 3,7 miliardi di anni di storia della vita sul pianeta (Pearce & al., 2018), hanno dovuto affrontare molto di peggio (Hull, 2015). Quello che avverrà, però, è che si andrà sempre più verso una riduzione e banalizzazione della biodiversità, con un minore numero di specie enormemente sovrarappresentate e un incontrollato affermarsi delle specie da noi introdotte o favorite. La perdita di biodiversità ha un impatto negativo sui servizi ecosistemici dai quali dipende la nostra esistenza (Cardinale & al., 2012), sulla salute umana in generale (Clark & al., 2014) e in particolare quella mentale (Aerts & al., 2018). Pertanto, queste dinamiche potrebbero anche avere come esito l’estinzione della nostra specie, che per certi aspetti potrebbe anche essere vista come una sorta di “liberazione” per il pianeta (Gray & Milne, 2018). Vogliamo andare in questa direzione?
Tornando alle specie vegetali aliene, potremmo affermare che le specie coltivate oggi (soprattutto a scopo ornamentale) potrebbero essere le invasive di domani. Per un banale principio di precauzione, quindi, sarebbe opportuno evitare l’uso di piante alloctone quando non strettamente indispensabile. Ben venga allora, per esempio, l’uso di specie autoctone di provenienza locale per il cosiddetto “verde urbano”, inclusi giardini privati, balconi etc. Una maggiore sensibilizzazione su queste tematiche, a partire dalle scuole, potrebbe certamente favorire comportamenti virtuosi, che potranno contribuire alla conservazione della biodiversità vegetale ma anche della nostra specie.
Bibliografia
Aerts R., Honnay O., Van Nieuwenhuyse A., 2018. Biodiversity and human health: mechanisms and evidence of the positive health effects of diversity in nature and green spaces. British Medical Bulletin, 127(1): 5–22.
Bar-On Y.M., Phillips R., Milo R., 1998. The biomass distribution on Earth. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(25): 6506–6511.
Cardinale B., Duffy J., Gonzalez A., Hooper D.U., Perrings C., Venail P., Narwani A., Mace G.M., Tilman D., Wardle D.A., Kinzig A.P., Daily G.C., Loreau M., Grace J.B., Larigauderie A., Srivastava D.S., Naeem S., 2012. Biodiversity loss and its impact on humanity. Nature 486, 59–67.
Ceballos G., Ehrlich P.R., Barnosky A.D., García A., Pringle R.M., Palmeret T.M., 2015. Accelerated modern human–induced species losses: Entering the sixth mass extinction. Science Advances 1: e1400253.
Chiarucci A., 2024. Le arche della biodiversità. Salvare un po’ di Natura per il futuro dell’uomo. Hoepli, 182 pp.
Clark N.E., Lovell R., Wheeler B.W., Higgins S.L., Depledge M.H., Norris K., 2014. Biodiversity, cultural pathways, and human health: a framework. Trends in Ecology and Evolution 2(4): 198–204.
Galasso G., Conti F., Peruzzi L., Alessandrini A., Ardenghi N.M.G., Bacchetta G., Banfi E., Barberis G., Bernardo L., Bouvet D., Bovio M., Calvia G., Castello M., Cecchi L., Del Guacchio E., Domina G., Fascetti S., Gallo L., Guarino R., Gubellini L., Guiggi A., Hofmann N., Iberite M., Jiménez-Mejías P., Longo D., Marchetti D., Martini F., Masin R.R., Medagli P., Musarella C.M., Peccenini S., Podda L., Prosser F., Roma-Marzio F., Rosati L., Santangelo A., Scoppola A., Selvaggi A., Selvi F., Soldano A., Stinca A., Wagensommer R.P., Wilhalm T., Bartolucci F., 2024. A second update to the checklist of the vascular flora alien to Italy. Plant Biosystems, 158: 297–340.
Genovesi P., 2024. Specie aliene. Editori Laterza, 184 pp.
Gray R., Milne M.J., 2018. Perhaps the Dodo should have accounted for human beings? Accounts of humanity and (its) extinction. Accounting, Auditing & Accountability Journal 31(3): 826–848.
Hejda M., Pyšek P., Jarošík V., 2009. Impact of invasive plants on the species richness, diversity and composition of invaded communities. Journal of Ecology, 97: 393–403.
Higgins S.I., Richardson D.M., Cowling R.M., Trinder-Smith T.H., 1999. Predicting the Landscape-Scale Distribution of Alien Plants and Their Threat to Plant Diversity. Conservation Biology, 13: 303–313.
Hull P., 2015. Life in the Aftermath of Mass Extinctions. Current Biology, 25(19): R941–R952.
Korzeniewski B., 2020. Self-Consciousness as a Product of Biological Evolution. Journal of Consciousness Studies, 27(7–8): 50–76.
Kontoleon A., Pascual U., Smale M., 2009. Agrobiodiversity conservation and economic development. Routeledge, 426 pp.
Mancuso S., 2018. L'incredibile viaggio delle piante. Editori Laterza, 144 pp.
Pearce B.K.D., Tupper A.S., Pudritz R.E., Higgs P.G., 2018. Constraining the Time Interval for the Origin of Life on Earth. Astrobiology, 18(3): 343–364.
Peruzzi L., Bedini G. (a cura di), 2024. Wikiplantbase #Toscana. http://bot.biologia.unipi.it/wpb/toscana/index.html
Pyšek P., Richardson D.M., Rejmánek M., Webster G.L., Williamson M., Kirschner J., 2004. Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. Taxon, 53: 131–143.
Richard T. Corlett R.T., 2016. Plant diversity in a changing world: Status, trends, and conservation needs. Plant Diversity, 38(1): 10–16.
Ruddimann, W.F., 2013. The Anthropocene. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 41: 45–68.
Simard S., 2022. L'albero madre. Alla scoperta del respiro e dell'intelligenza della foresta. Mondadori, 422 pp.
Torreggiani L., 2024. La “botanicstar” Stefano Mancuso paragona i migranti alle piante aliene scatenando la protesta di tre importanti Società scientifiche. Una riflessione sul bisogno urgente di complessità. L’Altra Montagna, 25 giugno 2024.
Vilà M., Espinar J.L., Hejda M., Hulme P.E., Jarošík V., Maron J.L., Pergl J., Schaffner U., Sun Y., Pyšek P., 2011. Ecological impacts of invasive alien plants: a meta-analysis of their effects on species, communities and ecosystems. Ecology Letters, 14: 702–708.
Wandersee J.H., Schussler E.E., 1999. Preventing plant blindness. The American Biology Teacher, 61(2): 84–86.
Wilson E.O., 1988. BioDiversity. National Academy Press, 538 pp.
Biodiversità e invasioni aliene
Museo di Storia naturale, Università di Pisa, via Roma 79, 56011 Calci (Pisa)
I pericoli maggiori alla perdita di biodiversità sono considerati l’uso del territorio (degradazione e alterazione del suolo, deforestazione, urbanizzazione, agricoltura), le specie aliene (competono con le specie native per spazio, cibo e altre risorse; possono diffondere malattie per le quali le specie native non hanno difese; ibridazione), l’inquinamento (i contaminanti rendono l’ambiente non adatto alla sopravvivenza delle specie sia in modo diretto, sia in modo indiretto), il cambiamento climatico (i contaminanti rendono l’ambiente non adatto alla sopravvivenza delle specie sia in modo diretto, sia in modo indiretto) e il sovrapopolamento (causa principale dell’impatto dell’uomo sulla biodiversità con sovra sfruttamento delle risorse) (Bellard et alii, 2022).
Le specie aliene, tipiche di zone della terra diverse da quelle in cui si possono rinvenire, a causa di fuga dalla cattività, rilascio intenzionale, trasporto passivo, eccetera, diventano invasive quando iniziano a riprodursi e a creare popolazioni stabili e autosufficienti (per una review si veda Davis et alii, 2011). I principali impatti o le interazioni competitive ipotizzati e/o riconosciuti possono essere, ad esempio, la predazione di specie locali (Ficetola et alii, 2011), l’alterazione della crescita delle specie autoctone (Pearson et al., 2015), il trasferimento di parassiti (Meyer et alii, 2015). Tutte queste relazioni producono direttamente o indirettamente una perdita di biodiversità (Wilcove et alii, 1998).
Il progetto LIFEASAP del 2015 (https://www.lifeasap.eu/index.php/it/progetto/progetto-asap) ha calcolato che in Europa ci sono circa 12000 specie aliene, il 76% in più negli ultimi 30 anni e in Italia più di 3000 specie aliene, il 96% in più negli ultimi 30 anni. I costi associati che i paesi europei sostengono, per monitorare, gestire e/o eradicare, ammontano a 12,5 miliardi di Euro ogni anno.
Il 22 ottobre 2014 è stato pubblicato il regolamento EU 1143/14 che introduce misure di prevenzione e lotta alle specie invasive di interesse unionale. Si tratta di 37 specie, 22 delle quali presenti in Italia. L’ IUCN (International Union for Conservation of Nature) ha prodotto un database, lo GISD (Global Invasive Species Database) sulle IAS (Invasive Alien Species) con 1096 specie aliene invasive (https://www.iucngisd.org/gisd/search.php, accesso il 25 luglio 2024), di cui 581 sono animali.
La situazione complessiva è pertanto drammatica, sia per l’entità del fenomeno, sia per la rapida espansione dei quantitativi registrati.
 |
Il caso che propongo si riferisce a una specie di lucertola, la lucertola campestre, Podarcis siculus, tipica dell’Italia continentale, peninsulare e insulare, che si estende anche nella parte settentrionale dei Balcani (Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovnia, Montenegro), nella Svizzera meridionale e in Corsica (Corti et alii, 2011; Sindaco et alii, 2016). Questa specie è stata introdotta in diverse parti del mondo (Burke et alii, 2002; Deichsel et alii, 2010; Kolbe et alii, 2013; Clemens et alii, 2021) e si è dimostrata particolarmente adattabile e plastica (D’Amico et alii, 2018; Adamopoulou e Pafilis, 2019).
Di recente, nell’ambito di ricerche e monitoraggio delle specie di rettili dell’Arcipelago Toscano, abbiamo potuto rinvenire la specie sull’Isola di Gorgona, ove la presenza non era mai stata segnalata prima. Il numero di individui osservati durante i primi monitoraggi (circa 180 contatti visivi), rappresentativo di tutte le classi di età, giovani, adulti, sia maschi sia femmine, indica una presenza stabile e quindi relativamente datata della specie. Abbiamo potuto campionare la parte terminale della coda di sette individui, con cui abbiamo svolto analisi genetiche. I risultati indicano che la specie è sicuramente di provenienza continentale e di tre diverse aree: Orti Bottagone (Oasi WWF a Piombino, tombolo della Giannella e Pisa (Zuffi et alii, 2022).
L’isola di Gorgona è sede di un carcere che ha diverse zone produttive, oliveti, vigneti di impianto relativamente recente (dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso) e allevamenti di capre, bovini, cavalli e maiali. Dalle aree di sovrapposizione degli aplotipi genetici registrati (gene mitocondriale CYB) proviene il foraggio che viene portato a Gorgona e il fatto correla perfettamente con le ipotesi di introduzione passiva della specie (Zuffi et alii, 2022), sicuramente a più riprese e che continua con regolarità.
Oltre alla specie introdotta, sull’isola sono presenti altre specie di rettili, il biacco (Hierophis viridiflavus), il geco comune (Tarentola mauritanica), l’emidattilo (Hemidactylus turcicus) e una specie di lucertola (Podarcis muralis), congenerica della lucertola campestre (Vanni and Nistri, 2006).
 |
La lucertola campestre, anche se endemica del territorio italiano, risulta in questo contesto una specie aliena, potenzialmente invasiva. Essa compare infatti sia nella direttiva (Habitat Direttiva 92/43/CEE), come specie protetta, ma anche nel Global Invasive Species Database come taxon invasivo. Studi successivi, non ancora pubblicati, con monitoraggi continuativi in habitat diversi dell’isola, ripetuti nel 2022, 2023 e 2024 hanno confermato la presenza della specie nelle aree e nei siti monitorati nel 2021, senza apparente espansione negli habitat frequentati da Podarcis muralis. Sebbene ritenuta invasiva in altre parti del mondo, dai nostri dati, la specie si è attestata negli habitat aperti e soleggiati dell’isola senza invadere le parti boschive, coperte e più fresche, dell’isola ove risulta comune solo la lucertola muraiola.
Almeno in questo caso, ritengo che il concetto di invasività di una specie andrebbe studiato con attenzione e per periodi medio lunghi, prima di attribuire caratteristiche altrimenti non dimostrabili.
Letteratura
Adamopoulou C., Pafilis P., 2019. Eaten or beaten? Severe population decline of the invasive lizard Podarcis siculus (Rafinesque-Schmaltz, 1810) after an eradication project in Athens, Greece. Herpetozoa 32: 165-169.
Bellard C., Marino C., Courchamp, F. 2022. Ranking threats to biodiversity and why it doesn’t matter. Nature Communication 13: 2616.
Burke R.L., Hussain A. A., Storey J.M., Storey K.B., 2002. Freeze tolerance and supercooling ability in the Italian wall lizard, Podarcis sicula, introduced to Long Island, New York. Copeia 2002: 836-842.
Clemens D.J., Allain S.J.R., 2021. An unusually high number of Italian wall lizards Podarcis siculus campestris entering Great Britain as stowaways. Herpetological Bulletin 156: 42.
Corti C., Biaggini M., Capula M., 2011. Podarcis siculus (Rafinesque-Schmaltz, 1810). In: Fauna d’Italia 47. Reptilia, pp. 407-417. Corti, C., Capula, M., Luiselli, L., Razzetti, E., Sindaco, R., Eds., Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, Direzione Protezione della Natura: Calderini Gruppo 24 Ore, Bologna.
D’Amico M., Bastianelli G., Faraone F.P., Lo Valvo M., 2018. The spreading of the invasive Italian wall lizard on Vulcano, the last island inhabited by the critically endangered Aeolian wall lizard. Herpetological Conservation and Biology 13: 146-157.
Davis M.A., Chew M.K., Hobbs R.J., Lugo A.E., Ewel J.J., Vermeij G.J., Brown J.H., Rosenzweig M.L., Gardener M.R., Carroll S.P., Thompson K., Pickett S.T.A., Stromberg J.C., Del Tredici P., Suding K.N., Ehrenfeld J.G, Grime J.P., Mascaro J., Briggs J.C. Don’t judge species on their origins. Nature 474: 153-154.
Deichsel G., Nafis G., Hakim J., 2010. Podarcis siculus (Italian Wall Lizard) USA: California. Herpetological Review 41: 513-514.
Ficetola G.F., Siesa M.E., Manenti R., Bottoni L., De Bernardi F., Padoa-Schioppa E., 2011. Early assessment of the impact of alien species: differential consequences of an invasive crayfish on adult and larval amphibians. Diversity and Distributions 7: 1141–1151
Kolbe J.J., Lavin B.R., Burke R.L., Rugiero L., Capula M., Luiselli L., 2013. The desire for variety: Italian wall lizard (Podarcis siculus) populations introduced to the United States via the pet trade are derived from multiple native-range sources. Biological Invasions 15: 775-783.
Meyer L., Du Preez L., Bonneau E., Héritier L., Quintana M.F., Valdeón A., Sadaoui A., Kechemir-Issad N., Palacios C., Verneau O., 2015. Parasite host-switching from the invasive American red-eared slider, Trachemys scripta elegans, to the native Mediterranean pond turtle, Mauremys leprosa, in natural environments. Aquatic Invasions 10 (1): 79–91.
Pearson S.H., Avery H.W., Spotila J.R., 2015. Juvenile invasive red-eared slider turtles negatively impact the growth of native turtles: Implications for global freshwater turtle populations. Biological Conservation 186: 115–121.
Sindaco, R., Restivo, S., Zuffi, M.A.L. (2016): Podarcis siculus (Rafinesque, 1810) (Lucertola campestre). In: Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali, pp. 282-283. Stoch, F., Genovesi, P., Eds, ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 141/2016, Roma.
Vanni S., Nistri A., 2006. Atlante degli anfibi e dei rettili della Toscana. Edizioni Regione Toscana, Firenze.
Wilcove D.S., Rothstein D., Dubow J., Phillips A., Losos E., 1998. Quantifying threats to imperiled species in the United States. BioScience 48 (8): 607-615.
Zuffi M.A.L., Coladonato A.J, Lombardo G., Torroni A., Boschetti M., Scali S., Mangiacotti M., Sacchi R., 2022. The Italian wall lizard, Podarcis siculus, unexpected presence on the Gorgona island (Tuscan Archipelago). Acta Herpetologica 17(2): 135-145.